Il sogno è un prodotto psichico individuale e tratta le psicodinamiche in atto secondo il suo linguaggio, ma ha anche radici culturali nei contenuti. In sostanza si sogna anche secondo la cultura occidentale, la nostra, ossia in base agli schemi interpretativi ed esecutivi della realtà elaborati tremila anni fa nella mitica Grecia, schemi a prevalenza razionale.
Nel sogno di Luca il richiamo culturale riguarda la “nostalgia”, la storia culturale della “nostalgia”. Il riferimento classico riguarda l’Ulisse di Omero e il poema basilare “Odissea”. Luca, come Ulisse, vive lo stesso “dolore del ritorno” a conferma che la psiche ha una sua universalità strutturale, organizzativa e culturale, pur mantenendo prioritaria la sua irripetibile individualità. Procedo.
IL SOGNO
 “Luca sogna di trovarsi a Siracusa con Sissy, la sua donna, e con Gringo e Cucciola, i loro cani. Alle ore 17 dello stesso giorno deve andare a lavorare in una cittadina del Veneto. Arriva a casa di suo zio a Siracusa e incontra i suoi genitori che gli suggeriscono di suonare il campanello per entrare. Risponde il cugino che apre la porta e Luca porta Sissy a vedere il giardino con i sedili di pietra dove giocava da bambino con i cuginetti.
“Luca sogna di trovarsi a Siracusa con Sissy, la sua donna, e con Gringo e Cucciola, i loro cani. Alle ore 17 dello stesso giorno deve andare a lavorare in una cittadina del Veneto. Arriva a casa di suo zio a Siracusa e incontra i suoi genitori che gli suggeriscono di suonare il campanello per entrare. Risponde il cugino che apre la porta e Luca porta Sissy a vedere il giardino con i sedili di pietra dove giocava da bambino con i cuginetti.
Vuole raccontare tante cose a Sissy, ma non riesce. Entra in casa dello zio e le fa vedere il piano terra della casa con le stanze enormi e la luce soffusa. Le dice che in Veneto non si potrebbero fare stanze di questo tipo e lei risponde che non è vero.
Sale con il suo cane Gringo al piano superiore e incrocia i cugini in accappatoio. Entra in salotto e vede la nonna, la zia, lo zio e il nonno seduti attorno a un tavolo. Il nonno ha una maglietta nera con le maniche corte. Luca saluta tutti e non sa se li deve baciare, perché non è la prima volta che li vede.
Il nonno lo saluta con indifferenza, mentre la nonna, che Luca era stupito di vedere, si alza in piedi e lo abbraccia e restano abbracciati per un po’ di tempo. Lei gli dice cose che non ricorda, ma del tipo di quelle che gli diceva sempre quand’era piccolo. Luca si sente in imbarazzo abbracciato alla nonna perché ci sono tante persone intorno. Nell’abbraccio non vede niente perché la nonna è imponente, alta e avvolgente.
Luca pensa anche che vuol far salire Sissy, poi pensa al cane Gringo e vede che è dietro di lui disteso per terra che gioca con un cuginetto. Si mette per terra con loro e pensa che deve andare a lavorare in Veneto, che poi sarebbe tornato a casa e che Sissy, Gringo e Cucciola l’avrebbero aspettato.”
I RIFERIMENTI
La parola “nostalgia” ha etimologia greca, si traduce “dolore del ritorno” e si associa a Ulisse, il classico eroe, sempre greco, che per ben dieci anni girovagò per il “mare nostrum”, il Mediterraneo, secondo la volontà degli dei e in espiazione della colpa di aver ordito l’inganno del cavallo di legno che aveva causato la distruzione della città di Troia e la morte dei suoi abitanti. Ebbene, dopo tanti naufragi e lunghe traversie, dopo aver perso tutti i suoi compagni, Ulisse ritorna a Itaca dal padre Laerte, dal cane Argo, dal figlio Telemaco, dalla moglie Penelope e dal suo popolo. Questa è la versione di Omero nel mitico, nonché magnifico, poema “Odissea”.
Dante non farà ritornare Ulisse a Itaca e dai familiari, ma lo immetterà nel “folle volo” al di là delle Colonne d’Ercole per “seguir virtute e canoscenza”, dopo averlo condannato all’Inferno e collocato nel girone dei fraudolenti. Nella visione morale di Dante “l’esistenza autentica” ambiva il sapere, “l’esistenza banale” esigeva il ritorno all’esercizio degli affetti; di conseguenza la “nostalgia” era assolutamente da risolvere in vista di un bene maggiore, la scienza.
Joyce farà smarrire Ulisse in un oceano di parole e forse Lacan, lo psicoanalista che individua la dimensione inconscia nella parola, lo avrebbe fatto naufragare nel “Profondo psichico”. Quest’ultima definizione mi appartiene.
LA TEORIA
Ma chi è Ulisse nel registro psichico e nella teoria dei fantasmi? Ulisse è il simbolo riconosciuto dell’astuzia o dell’intelligenza operativa, include il sentimento della “nostalgia” proprio perché il poema “Odissea” è incentrato sull’umano sentimento del ritorno dai familiari e nella terra natia. E il “dolore del ritorno” di Ulisse fu tanto e tanto forte nella versione omerica. La “nostalgia” comporta un “oggetto dentro”, un’esperienza vissuta, e un “oggetto fuori”, una persona o una terra reali su cui si vuol affettivamente reinvestire. A questi “oggetti” si può e si vuole ritornare e nell’attesa si soffre. La “nostalgia” è un sentimento che non verte su un oggetto che non esiste fuori, un parente morto, perché questo è dolore nudo e crudo. La “nostalgia” s’incentra sul vissuto in riguardo al passato e su un oggetto reale, per l’appunto. A livello psichico la “nostalgia” è un sentimento struggente legato al “fantasma di perdita” e appartiene al ricco corredo dell’umana e naturale dimensione depressiva. L’appagamento della “nostalgia” è soltanto un fatto psichico e avviene con la “fantasia” e con i “processi primari” che, da svegli o da dormienti, allucinano il desiderio di rivivere quel passato riattualizzandolo. La “nostalgia”, quindi, resta sempre “dolore del ritorno”, ma a livello psichico si realizza all’interno della “breve eternità” del tempo presente che contraddistingue la funzione psichica. La “fantasia” è un’attività psichica vigile e finalizzata alla realizzazione di pulsioni, di desideri, di bisogni più o meno coscienti. La parola “fantasia” deriva dal greco arcaico “phas” o “phaos” e si traduce con “allucinazione”, quindi la “fantasia” illumina da svegli la “fantasticheria” e allucina da dormienti il “sogno” e nello specifico il materiale psichico profondo riportandolo alla luce della coscienza in maniera traslata secondo i meccanismi di difesa e componendolo secondo le modalità del “pensiero primario”.
Ritornando a Ulisse e alla simbologia inerente al sentimento della “nostalgia”, bisogna decodificare gli oggetti reali del suo struggimento: il padre Laerte, il figlio Telemaco, il cane Argo, la moglie Penelope, l’isola di Itaca e il popolo di Itaca, per meglio intuire l’intensità dell’emozione legata alla benefica o malefica “nostalgia”. Il padre Laerte condensa le origini e il senso del sacro, il figlio Telemaco rappresenta l’investimento della “libido genitale” e l’oggetto della “pietas” paterna, il cane Argo simboleggia la dipendenza dell’alleato affettivo, la moglie Penelope attesta l’universo femminile e i valori del nucleo familiare, l’isola di Itaca condensa la formazione psichica, il popolo di Itaca rappresenta l’oggetto culturale e politico del potere benevolo. Ulisse, quindi, soffriva per la frustrazione continua degli affetti in riguardo agli oggetti psichici suddetti. Ecco la sintesi più chiara! La “nostalgia” è il dolore causato da una frustrazione affettiva. Questo è anche un cardine esplicativo: lo struggimento è prodotto dalla vanificazione dell’esercizio degli investimenti della “libido” e, in particolare, in riguardo all’affettività. La “libido” ristagna e degenera nel dolore acerbo di una maligna spira depressiva.
LA DECODIFICAZIONE DEL SOGNO DI LUCA
Quest’ampio preambolo serve a introdurre degnamente la valenza “nostalgia” del sogno di Luca, un sentimento sotteso e mai del tutto esplicitato. La “nostalgia” si evince dalle forti emozioni vissute nello svolgimento della psicodinamica affettiva, il lungo e avvolgente abbraccio con la nonna, e dai due piani topici e temporali, i luoghi del Veneto e della Sicilia, il tempo oggi e il tempo ieri. L’attualità psichica e il passato psichico si presentano nella cornice di un “breve eterno” grazie alle mirabili proprietà del sogno di riattualizzare le esperienze vissute e di comporle in maniera compatibile secondo le modalità del “processo primario”. Ma il sogno e le sue virtù non sono da meno in riguardo allo spazio. Luca mette insieme Veneto e Sicilia e oscilla con naturalezza tra il nord e il sud della bella Italia. Il sogno unifica lo spazio e il tempo in un’unica dimensione, lo “spaziotempo”, categoria ipotizzata e ricercata attualmente dai fisici e dagli astrofisici per l’universo. Lo stesso Freud aveva detto, a tal proposito, che la Psiche non riconosce lo spazio e il tempo così come sono determinati nella realtà dalla scienza fisica.
GRAZIE SOGNO PER LE MERAV IGLIE CHE CI OFFRI !
In effetti, i vissuti di Luca s’intersecano senza confondersi: il lavoro nel Veneto e la realtà affettiva del cane e della sua donna, le esperienze vissute da piccolo nel contesto familiare allargato e il confronto tra la sua esperienza siciliana e quella veneta. Il suo “ritorno al passato” si evolve dalla sua realtà psichica in atto e si conclude con il “ritorno al presente” con un unico biglietto di andata e ritorno.
UN “BREVE ETERNO” ! UNO “SPAZIOTEMPO” !
Luca non può, di certo, rivivere le parti psichiche intriganti del suo passato con un semplice ritorno a Siracusa, il luogo, dai parenti prossimi e rimasti in vita, gli affetti, ma può veramente rivivere in sonno e in sogno, senza le ristrettezze della vigilanza dell’”Io” e del “principio di realtà”, una parte importante della sua formazione affettiva. Mirabile è il “principio del piacere” che contraddistingue il sogno. Da sveglio Luca può elaborare con la “fantasia” quei momenti, quei luoghi e quei personaggi che hanno riempito la sua infanzia. Da dormiente Luca in sogno può riattualizzare e rivivere gli stessi temi in maniera allucinatoria con l’autenticità dei risvolti emotivi e appagando il suo desiderio: “processo primario” e “principio del piacere”.
IL SOGNO E’ AUTENTICO !
Luca ha due realtà affettive in atto, la pregressa che ha formato parte del suo carattere, l’attuale che lo appaga e lo completa nel suo divenire. Il sogno, come si è detto ampiamente in precedenza, verte chiaramente sul rimando temporale tra passato e presente, sul rimando geografico tra Veneto e Sicilia e sviluppa in maniera lineare queste apparenti discrepanze nella cornice di un presente affettivo e di un’attualità psichica senza ombre regressive e tanto meno dolorose.
IL FANTASMA
Il sogno di Luca è discorsivo e psicodinamico, ma non si esime dal porre un “fantasma” in riguardo alla figura materna. Il sogno si difende dall’eventuale angoscia tramite il meccanismo dello “spostamento” e della “condensazione”, la nonna al posto della madre. Luca trasla nella nonna il suo attaccamento affettivo di qualità avvolgente nei riguardi della madre e nel sogno lo può sviluppare tutto fino al sopravvento del pudore. Eccolo!
“…la nonna, che Luca era stupito di vedere, si alza in piedi e lo abbraccia e restano abbracciati per un po’ di tempo. Lei gli dice cose che non ricorda, ma del tipo di quelle che gli diceva sempre quand’era piccolo. Luca si sente in imbarazzo abbracciato alla nonna perché ci sono tante persone intorno.”
Si evince chiaramente l’intensità affettiva e il volume del “fantasma” materno.
Si manifesta eclatante un bisogno fusionale con la madre all’interno di un contesto sacrale. I bambini vedono sempre, nel sogno e nella veglia, i genitori come figure maestose, sia per un fatto fisico, l’essere adulti, e sia per un fatto psichico, la dipendenza. Ritornando al sentimento del pudore, ”Luca si sente in imbarazzo abbracciato alla nonna perché ci sono tante persone intorno”, si evidenzia in maniera netta il sentimento della “rivalità fraterna” nelle “tante persone intorno”. E’ chiaro che Luca non è figlio unico, il solo e il singolo e il privilegiato, l’erede universale dei beni materni. Luca condivide la madre e questa condivisione è un fattore responsabile nella formazione del carattere e nello specifico del “fantasma della madre” con la qualità di “imponente, alta e avvolgente”. Il fatto che “nell’abbraccio non vede niente” attesta della purezza di questa emozione e dell’autenticità di questo bisogno di Luca “infante”, “senza parole”. Nel presente del sogno si condensano i bisogni affettivi di allora sotto la benefica forma traslata della nonna; quest’ultima, a suo tempo, ha colpito nel segno e ha lasciato un ottimo “imprinting”, se può tranquillamente presentarsi gratificante e non conflittuale nel sogno. La nonna è il tramite e l’alleato che consente alla psiche di confezionare un bel sogno senza patemi e senza angosce, senza regressioni e senza sublimazioni. Tutto questo accade al di là di come la madre si è offerta nella realtà. Il sogno siamo noi e, quindi, i vissuti vanno ascritti al sognatore.
IL SOGNO SIAMO NOI !
Questa è la parte affettiva pregressa del sogno di Luca, una parte importante del suo carattere, tecnicamente detto “formazione reattiva”. Andiamo a disoccultare la parte in atto: la resistenza a liberare l’affettività negli investimenti della “libido. All’uopo il sogno ci offre un consistente assaggio:
“Vuole raccontare tante cose a Sissy, ma non riesce.”
La psicodinamica con Sissy presenta un blocco nella parola, “infante”, Luca non sa parlare del suo passato a Sissy che rappresenta in primo luogo se stesso, difesa della “traslazione”, e di poi, soltanto di poi, l’altro da sé, Sissy e tutti gli altri. Luca non sa parlare di sé a se stesso in riguardo al suo trascorso affettivo e in atto nel suo presente psichico. Il sogno suggerisce con dolcezza a Luca di integrare in maniera proficua nella sua casa psichica la dimensione affettiva per farne un tutto armonico e atto alla migliore possibile “coscienza di sé”. Quest’operazione serve per favorire “l’autonomia”, il “far legge a se stesso”.
IL SOGNO E’ TERAPIA
Il blocco della parola si snoda subito in una paura che sembra un pregiudizio, ma che in effetti è soltanto una paura allo stato puro e viene risolta successivamente con il ripensamento.
“Entra in casa dello zio e fa vedere a Sissy il piano terra della casa con le stanze enormi e la luce soffusa.”
Luca sta riconoscendo una parte della sua formazione psichica, quella legata alla sua reiterata esperienza siracusana durante l’infanzia e l’adolescenza, stagioni di grande trambusto psicofisico in cui avviene e si completa la formazione del carattere. Luca attribuisce a Sissy la conoscenza di una sua esperienza esistenziale legata alla Sicilia, vissuti oggetto del sogno insieme all’altra parte della sua esperienza di vita, il teatro del Veneto. “Piano terra”, “stanze enormi”, “luce soffusa”: ecco i fantasmi con cui Luca ha condensato nel sogno la sua esperienza psichica nella terra di Archimede. Decodifichiamo: Il “piano terra” della casa rappresenta a livello intellettivo la concretezza pragmatica, l’intelligenza operativa, la fattività legata all’azione, la funzione attiva e deliberante dell’”Io”. A livello sentimentale condensa un legame alla terra e all’universo femminile, alle madri e all’isteria, alle pulsioni e alle emozioni: un tratto caratteriale uterino. Le “stanze enormi” sono il simbolo di una buona recettività psichica e di una variegata duttilità sentimentale, di un’abnorme generosità e di un’acritica disposizione. Le “stanze enormi” accolgono ma contengono, ricevono ma adattano: l’ospitalità è un simbolo femminile e ha un suo prezzo. La “luce soffusa” rappresenta la parte crepuscolare della coscienza, l’emotività in eccesso e la riduzione della funzione moderatrice dell’”Io” rispetto alle pulsioni dell’”Es”, la caduta della vigilanza razionale e l’avvento del senso-sentimento. Luca vuole comunicare a Sissy la diversità della sua formazione psichica facendole vedere e visitare la casa, simbolo della psiche, e sostenendo che esiste una maniera diversa di vivere ed esternare l’affettività in Sicilia rispetto al Veneto.
“Le dice che in Veneto non si potrebbero fare stanze di questo tipo e lei risponde che non è vero.”
Lei è lui. Luca sa le cose giuste, ma si difende dal prendere coscienza dell’importanza d’integrare la sua sfera psichica affettiva nel versante siculo e nel versante veneto. Luca deve capire che la diversità culturale è stata vissuta come una frattura nella sua “formazione reattiva”, il carattere, come una ferita legata allo sbalzo psichico, come un “fantasma di perdita”, prevalentemente affettiva in questo caso. Luca deve accomodare questi tre punti e operare una panacea alle sue difficoltà trasformandole in virtù.
Questo per quanto riguarda la relazione con se stesso. Per quanto riguarda la relazione con l’altro da sé, Sissy in prima istanza, serve la parola: il dono di parti di sé, l’investimento di “libido”, la comunicazione e la condivisione, la sicurezza e la generosità. La “parola mitica” è energia vitale, creazione, evoluzione, espressione della dimensione psichica profonda. La “parola fantasma” è “libido genitale”, piacere del dare, presenza e cura. La “parola sociologica” è retorica o arte del persuadere, oratoria o arte del bel dire, eristica o arte del convincere. Ricordiamo che il vangelo di Giovanni esordisce con “In principio era il Verbo” e tesse le lodi creative della parola divina. Il “fantasma della parola” si traduce in dimensione inconscia e creatività, isteria e catarsi, affetto e relazione, identità psichica. Ritornando al portentoso abbraccio con la nonna, Luca “non vede niente” ossia si abbandona all’emozione e al sentimento sospendendo le funzioni dell’”Io”; inoltre, attribuisce alla nonna le parole che non ricorda, ma che pensa riguardino i sentimenti d’amore esplicitati dalla nonna al suo essere bambino.
Procediamo con le figure genitoriali. All’inizio del sogno si erano profilate, ma Luca le aveva congedate in maniera rapida e chiara.
“Arriva a casa di suo zio a Siracusa e incontra i suoi genitori che gli suggeriscono di suonare il campanello.”
Non ci sono particolari simboli e tanto meno conflitti, ma soltanto genitori semplici e didattici che aiutano a risolvere problemi pratici. Di poi, subentra il “fantasma materno” nella figura della nonna e il “fantasma paterno” nella figura del nonno. Della “nonna-madre” si è detto ampiamente, mentre del “nonno- padre” il sogno offre i seguenti dati.
“Il nonno ha una maglietta nera con le maniche corte”, “Il nonno lo saluta con indifferenza”.
La figura paterna non è dominante anche perché simbolicamente la sfera psichica affettiva, di cui ampiamente il sogno di Luca tratta, si ascrive alla madre e all’universo femminile. Dominano nella figura paterna la dimensione spartana e giovanile nell’abbigliamento e l’assenza di conflitti nell’”indifferenza”, almeno per quanto riguarda la psicodinamica affettiva in questione. Il simbolo dell’indifferenza recita: difesa dal coinvolgimento emotivo e dagli “investimenti della libido”, ma nel sogno di Luca prevale la sfera affettiva e di conseguenza la madre. Il padre resta in questo caso una figura “a latere”.
Particolare attenzione merita il cane Gringo proprio per il tema dominante dell’affettività. Gringo è l’oggetto privilegiato su cui Luca investe al sicuro i suoi capitali affettivi, a cui si concede con naturalezza, a cui si affida e di cui si preoccupa e si prende cura.
“…e con i cani, Gringo e Cucciola”.
Gringo è l’”alter ego” affettivo di Luca, se stesso e l’altro da sé come oggetti d’amore, come campo d’amare. La “libido narcisistica”, a suo tempo non adeguatamente vissuta per la rivalità fraterna, viene recuperata e fusa con la “libido genitale”, quella donativa e a cui non mancano le parole, quella adulta e non infante, quella che si abbandona fiduciosa nel dare piacere e nel prendere godimento. Gringo è la condensazione di Luca, che non è il suo padrone, ma il suo equivalente o sostituto.
“Sale con il suo cane Gringo al piano superiore”.
Quest’ultimo rappresenta il processo di difesa della “sublimazione della libido”. Mai si potrà definire in maniera più appropriata l’amore verso il proprio cane: un investimento sublimato. Gringo lo segue come un’ombra, ma non è invadente ed esclusivo perché consente a Luca di distribuirsi nel sogno sicuro che lui c’è.
“…poi pensa al cane Gringo e vede che è dietro di lui disteso per terra che gioca con un cuginetto. Si mette per terra con loro…”
Il gioco crea fusionalità e complicità, le classiche e necessarie doti del sentimento d’amore e le parole veicolano questo sentimento. L’empatia è suggestiva, ma può essere un grosso equivoco, un fraintendimento magico, un’illusione conveniente. Luca fa con Gringo le cose giuste in attesa che di prendere coscienza e di attuarle con se stesso e, di poi, con gli altri. L’investimento e l’affidamento sono i sentimenti giusti della “libido donativa”.
LA CONCLUSIONE
Il sogno ha il suo epilogo nel “ritorno al presente” affettivo, ai legami e ai sentimenti in atto con il ritorno nel Veneto e con la vita di tutti i giorni, una quotidianità che può non essere brillante, ma che dà grande sicurezza.
“…pensa che deve andare a lavorare in Veneto, che poi sarebbe tornato a casa e che Gringo e Carmela l’avrebbero aspettato.”
“Aspettato” è la parola che denota l’interesse affettivo degli altri. Luca è importante per Sissy, per Gringo e per la povera Cucciola che nel sogno è stata soltanto marginalmente coinvolta. Il sogno ha operato un bel servizio per dire e per prendere coscienza. Il sogno ha detto che, come Ulisse, la formazione affettiva si avvale di un ritorno al presente con Sissy, Gringo, Cucciola, i nonni genitori, i fratelli e altri personaggi non certo minori che vogliono, a diverso titolo e modo, bene a Luca. Per quanto riguarda la nostalgia, è auspicabile contenerla nelle giuste dimensioni emotive di un ritorno gratificante al passato, di una distensione dell’anima al passato, come voleva il grande Agostino di Tagaste in riguardo al tempo e all’eternità.
IL SOGNO E’ DIAGNOSI E PROGNOSI
La prognosi impone a Luca di comporre la formazione caratteriale integrando al meglio la componente affettiva, di non abdicare alla conoscenza di sé e degli altri, di fidarsi degli investimenti di “libido”, di conoscersi e di farsi conoscere, di usare il paradigma affettivo “Gringo” negli affetti in atto e in divenire. Inoltre, la prognosi sollecita la risoluzione del micidiale “sentimento della rivalità fraterna”, responsabile in gran parte della sfera affettiva e delle psicodinamiche conseguenti. Per quanto riguarda la “nostalgia”, il “dolore del ritorno”, bisogna comporla nell’eterno presente e viverla come la riattualizzazione della propria significativa esperienza formativa.
Il rischio psicopatologico si attesta nel tralignare della “nostalgia” e della “rivalità fraterna” nel “fantasma di perdita” con struggimenti legati alle frustrazioni della sfera affettiva e nel portare avanti psicodinamiche affettive insoddisfacenti che aspettano di essere completate.
Riflessioni metodologiche: mi preme precisare il simbolo del “cane”, al di là del trattamento riservato a Gringo da Luca nel sogno, un significato dettato dal contesto in cui il benedetto alleato era stato inserito, suo malgrado o suo bengrado. Il “cane” condensa l’affidamento acritico e la dipendenza psichica, l’alleato e l’oggetto su cui si possono trasferire i fantasmi, la traslazione di un investimento libidico di qualità prevalentemente affettiva. Altra precisazione teorica importante: la “nostalgia” non implica la “regressione” intesa clinicamente come “processo di difesa dall’angoscia”. La “nostalgia” sembra una regressione temporale in quanto riporta la psiche a svolgere psicodinamiche legate alle esperienze vissute, ma in effetti è un “ritorno al presente”, un rivivere e un rivisitare, un riattualizzare a conferma che la Psiche esula dalla categoria temporale in quanto gode di un “breve eterno”, breve perché dura soltanto una vita. Ancora: il sogno di Luca consente di formulare simbolicamente la “personalità mafiosa” a dispetto della benamata e benemerita Nancy McWillians e del suo formidabile libro “La diagnosi psicoanalitica. La struttura della personalità e processo clinico”. La “personalità mafiosa” si attesta simbolicamente nel “piano terra della casa con le stanze enormi e la luce soffusa.” oltre all’usanza del bacio: “…non sa se li deve baciare”. Chi mi sta leggendo penserà che sono un siciliano burlone, ma si sbaglia perché non mi sto riferendo all’organizzazione criminale, la mafia, ma alla cultura, a un dato culturale, a un’interpretazione di se stessi e della realtà, uno schema che alberga e impera. La riporto: il “piano terra” della casa rappresenta la concretezza pragmatica, l’intelligenza operativa, un legame all’universo femminile, alle madri, alle pulsioni isteriche, mammasantissima”, e alle emozioni forti. Le “stanze enormi” sono il simbolo di una buona recettività psichica e di una variegata duttilità sentimentale, di un’abnorme generosità e di un’acritica disposizione. Le “stanze enormi” accolgono ma contengono, ricevono ma adattano: l’ospitalità è un simbolo femminile e ha un suo prezzo. La “luce soffusa” rappresenta la parte crepuscolare della coscienza, l’emotività in eccesso e la riduzione della funzione moderatrice dell’”Io” rispetto alle pulsioni dell’”Es”, la caduta della vigilanza razionale e l’avvento del “senso-sentimento”. Questo è quanto.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.psiconline.it/
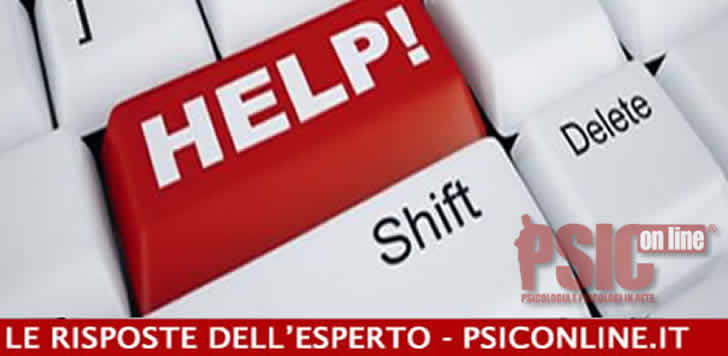






Commenti